La mostra “Vetrine” dedicata ad Andy Warhol e curata dal
critico d’arte Achille Bonito Oliva, inaugurata il 18 aprile e che sarà
visitabile fino al 20 luglio, è un viaggio nel genio di Warhol e nella sua
concezione della società, dipanato in ben 180 espressioni della sua produzione.
Location il Pan, il Palazzo delle Arti partenopeo, in via dei Mille, 60.
Warhol, padre, della pop art (arte popolare), introduce con
forza il concetto di arte seriale, un’arte che può moltiplicarsi all’infinito,
identica a sé stessa o con poche varianti sostanziali.
“Il pennello è frutto di produzione industriale, così come
la tela – scrive -. Di conseguenza anche il suo prodotto, ossia l’arte, è
industriale”.
Con la sua ottica dissacrante Warhol sovverte il concetto di
un’opera d’arte frutto del genio artistico unico ed irripetibile, di un’arte
frutto di un talento di matrice artigianale e quindi inimitabile.
Figlio e rappresentante del consumismo americano e del
trittico produzione –consumo-successo Warhol afferma che “agli Americani non
piace vendere, preferiscono buttare, al contrario di Europei ed Orientali, che
sono sempre intenti a mercanteggiare e contrattare, mentre gli Americani amano
comprare: beni, gente e Paesi”.
Figura eclettica, Warhol naviga a vista in tutte le arti
figurative (pittura, scultura, fotografia, cinema) e le contamina con altri
linguaggi come la musica.
Nella sua Factory, nata da un’idea di “comunità” dove il
talento sia messo in comune e le opere siano liberamente fruibili, alleva
giovani artisti: da Basquiat, padre della street art, a Keith Haring.
Giovani talenti che collaborano alla stesura della sua
rivista Interview.
Partito dal mondo della pubblicità, illustrando le copertine
di dischi famosi come quelli dei Rolling Stones, dei Velvet Underground, di
Paul Anka (The Painter) e di molti altri approda all’allestimento di vetrine
dove comincia ad inserire sculture ed exhibit dalla funzione più propriamente
artistica.
Ciononostante non disdegna di tornare a fare incursioni nel
mondo della pubblicità e delle vetrine anche in fasi posteriori quando ormai si
è affermato artisticamente.
Non a caso dice “Ho cominciato a fare soldi per la
produzione industriale, voglio morire facendoli nel mondo del business” e
ancora “Fare soldi nel mondo degli affari è la più grande forma di arte”.
Acutamente consapevole delle radici della morale, di matrice
niezschiana, secondo cui “la morale non è nient’altro che un comportamento che
le persone si auto impongono nel timore del giudizio degli altri e per
soddisfarne le aspettative, Warhol traspone nella sua espressione artistica
l’apoteosi del culto della personalità.
Ecco perché le persone si mettono “in vetrine” mostrando di
sé solo quello che gli altri vogliono vedere, il lato più pubblico e
“desiderabile” ed occultando la parte più fragile ed “oscura", ad arte.
Da una parte, campeggiano le sue foto trasformate in
serigrafie (tecnica tipica dell’ambito tipografico seriale, dove tutto
dev’essere perfettamente moltiplicato in esemplari identici), riprodotte con
grandi e piccole variazioni di colore, uguali, eppure diverse nelle
imperfezioni che vengono conservate. Appiattite in un’unica dimensione dove
figura in primo piano e ombra “giacciono” sullo stesso livello.
Dall’altra, con un
ritorno all’ambito prettamente industriale, ci sono i suoi oggetti di uso
quotidiano fatti diventare opere d’arte,
come i fustini del Brillo, le cassette in legno della Coca – cola con tanto di
bottigliette, ed i barattoli ed i fusti della Campbells Soup.
Oggetti che a volte si limita a firmare altre volte
riproduce serigrafandoli.
Nelle gigantografie dei visi da una parte egli prende delle
persone (o per meglio dire personaggi) famosi nell’epoca e li rende icone
eterne, protagonisti dell’immaginario collettivo: si pensi alle serigrafie
policromatiche di Marylin Monroe.
Dall’altro dimostra come e il giusto tocco di glamour, e del
maquillage, quindi con il giusto travestimento (si pensi alle sue opere di
camouflage), tutti possano diventare dei vip.
E’ il caso delle serigrafie su commissione come quelle per i
coniugi Bennardo, che divennero per l’artista una delle maggiori forme di
guadagno.
Invece nei barattoli e nei fustini troviamo il culto del
marchio aziendale. Ad esempio, la
Campbells lanciò una campagna promozionale per la quale
all’acquisto di cinque confezioni di zuppa si aveva in regalo un vestito con il
suo marchio. Warhol, nella sua idea di riproducibilità, prese quel vestito, vi
aggiunse la sua forma e le sue serigrafie più conosciute e ne fece un gadget
“appettibile” da vendere, una sorta di status symbol.
La vanità umana… una delle maggior tentazioni…sia per vip
che per gente comune… e Warhol lo sapeva bene e sapeva come “corteggiare”
l’egocentrismo.
Alchemico il suo rapporto con Napoli che egli ritiene una
città “unica e fantastica”, di cui adora i travestiti, i rifiuti ed i palazzi,
dall’equilibrio precario, tenuti insieme con una corda.
Non a caso, grazie a Lucio Amelio ed al suo atelier
artistico in piazza dei Martiri, una serie di artisti, con al centro Warhol,
troveranno nel capoluogo partenopeo un luogo dove potersi esprimere liberamente
e confrontarsi.
La contemporaneità è abitata da contraddizioni: nel suo
affermare la democraticità dell’arte come serialità Warhol riafferma anche
l’unicità dell’individuo e lo sottrae alla massificazione ed al tutto
indistinto del nichilismo.
E’ il caso della figura dei trans, "i femminielli" che tanto lo
affascinavano, che egli rende protagonisti delle sue opere, tanto nella
versione partenopea, che in quella newyorchese delle Drag Queen dei club
americani, rimarcandone la precisa connotazione sociale, antropologica,
esistenziale ed economica.
La stessa operazione la fa nell’opera “Fate Presto”, dove
prende una pagina del Mattino che parla dei ritardi dei soccorsi dopo il
terremoto del 1980 (dopo diversi giorni si sentiva ancora gente che gemeva
sotto le macerie in attesa di un soccorso latitante) e lo sdoppia nelle tre
fasi dello sviluppo fotografico: il negativo, l’immagine in controluce che sta
affiorando sulla pellicola e la pagina di giornale vera e propria, riprodotta
in una gigantografia.
Protagonista indiscusso della sua opera è anche l’enorme
vulcano che lo atterriva per la sua unicità (a New York potrebbe essere
paragonabile solo all’Empire State Building, diceva) ed insieme lo affascinava
(per me la forza di un’eruzione è paragonabile a quella della deflagrazione
della bomba atomica).
Eppure nella sua mostra Terrae Motus, pur riconoscendo la
forza terribile ed unica di questo gigante, lo rende riproducibile ed imitabile
in serie e dimensione con poche o tante varianti di colore.
Tra i fattori in grado di “irretire” Warhol c’è il, visto
anche qui come carnalità consumata in fretta e mercificata, come un atto
meccanico e ripetitivo al pari dei gesti che si compiono nelle riproduzioni
serigrafate.
Nelle copertine dei dischi da lui curate, introduce con
forza ed in maniera esplicita l’elemento sessuale: si pensi alla Banana della copertina
dell’album Velvet Underground & Nico, o ancora ai boxer che diventano
protagonisti (fronte/retro) della copertina di un altro disco dove è riprodotto
un jeans con tanto di zip vera. O ancora al riferimento fortemente sessuale nel
suo film Blood for Dracula (Dracula cercò sangue di vergine e… morì di sete!) e
di quello in cui riprende, con la telecamera fissa per ben 35 minuti, l’espressione di un uomo, ripreso a pochi
centimetri dal viso, (lo stesso modo che aveva di fotografare) che riceve una fellatio.
Figlio del funzionalismo americano, incentrato sulla
misurabilità di ogni fenomeno di stampo positivista, suole dire “Non vi
soffermate sul senso delle parole che la gente dice di voi ma misuratele in
centimetri”.
Warhol è tra gli artefici non solo del ponte gettato tra
Napoli e New York, tra similitudini e differenze, ma anche di quello teso tra
il capitalismo americano e il concettualismo di matrice europea, approdato in America
negli anni ’60.
Non a caso, Warhol, condivide con il francese (naturalizzato
Americano) Marcel Duchamp, l’idea della necessità di un processo di
democratizzazione dell’arte, in cui quest’ultima non sia un bene d’elite,
comprensibile e fruibile da pochi, bensì qualcosa che deve appartenere a tutti.
E’ per questo che il francese Duchamp decide di sovvertire
l’idea dell’arte come di qualcosa che è suscettibile di un’unica
interpretazione e frutto di un modo di dipingere e scolpire univoco, ma arriva al
traguardo in cui ogni cosa può essere arte, anche un orinatoio capovolto, che
egli ribattezza “Fontana” (è infatti questione di interpretazione e di punti di
vista).
Egli strappa la tela su cui è dipinta l’opera d’arte e
mostra senza remore il processo di creazione della stessa, i concetti ed il
mondo emotivo, ma anche la quotidianità, fatta di tante miserie umane, che c’è
dietro.
Come al solito la contemporaneità è terra di profonde
contraddizioni, di antitesi e di forze opposte che finiscono per annullarsi.
Perché se tutto può essere arte, nulla alla fine lo è per
davvero.
*Consulenza ad opera dell’artista Luigi Auriemma http://www.luigiauriemma.altervista.org

.jpg)


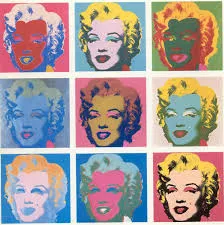








.jpg)


Nessun commento:
Posta un commento